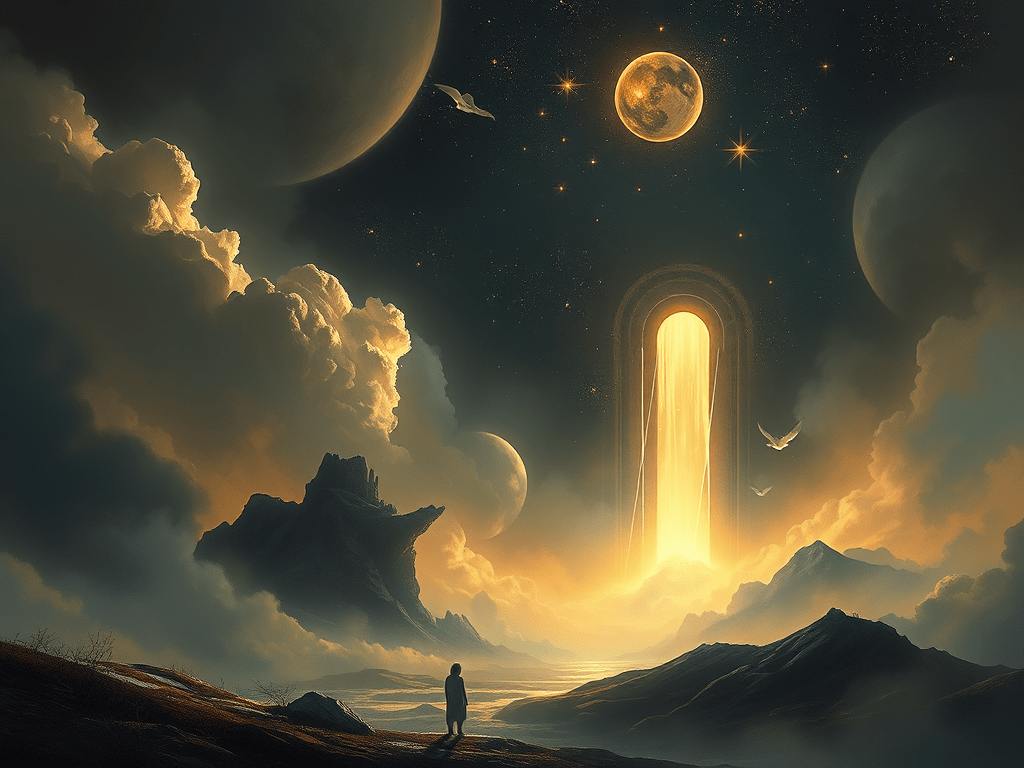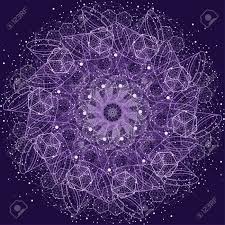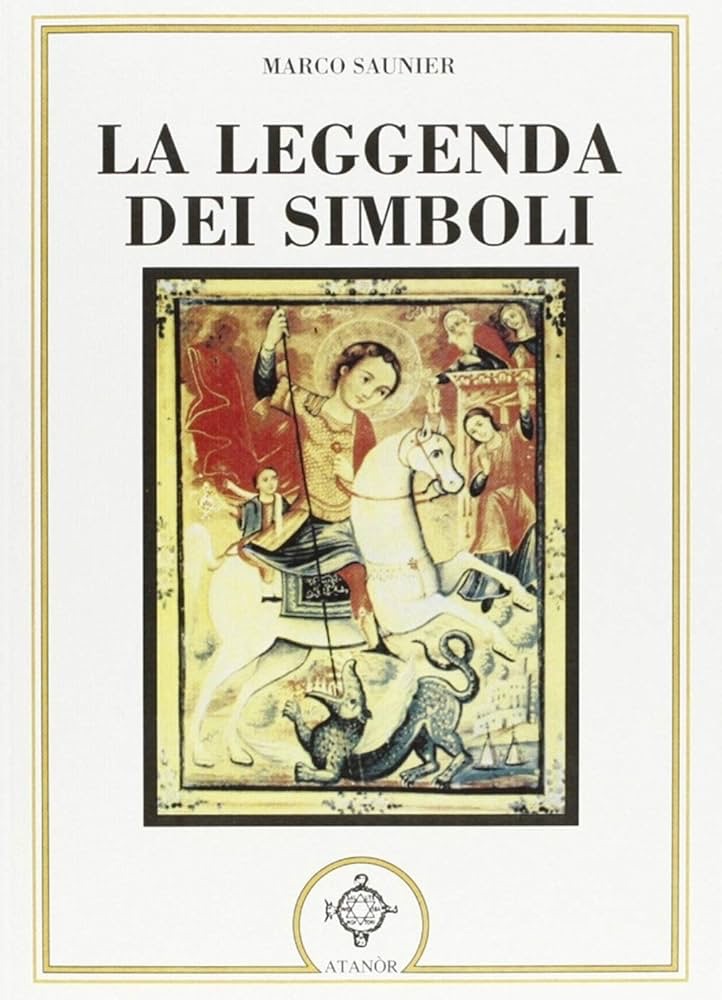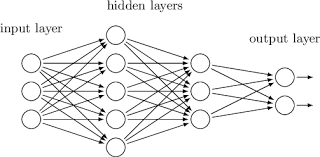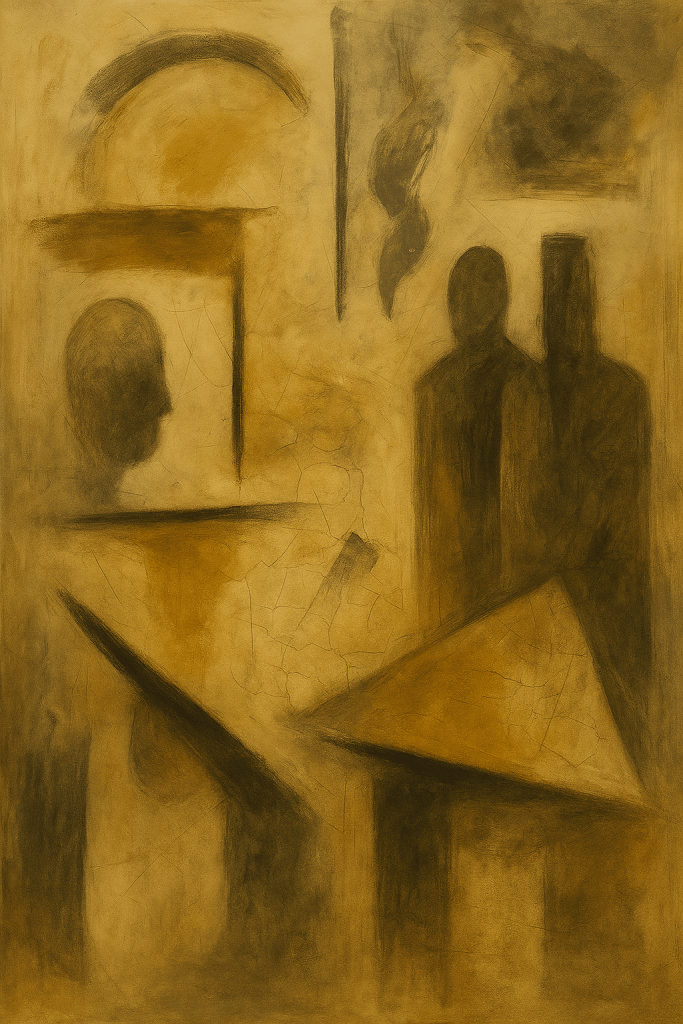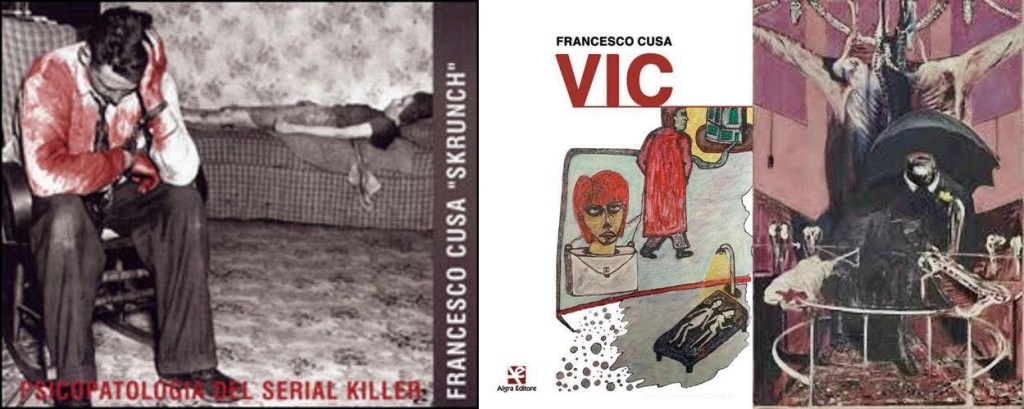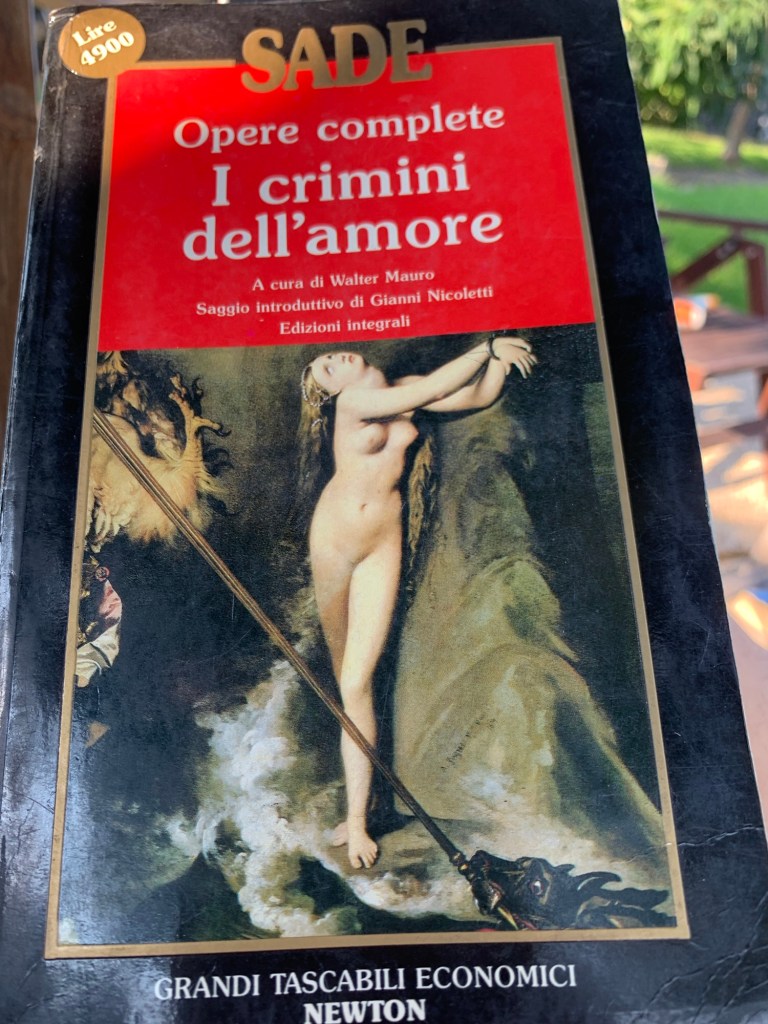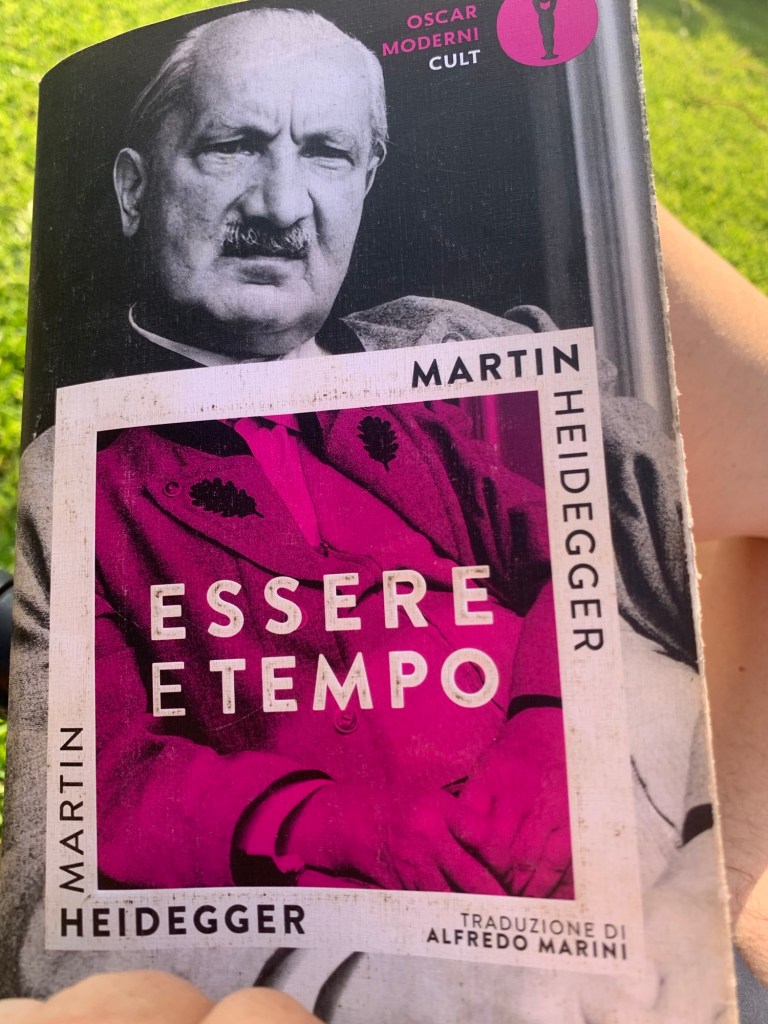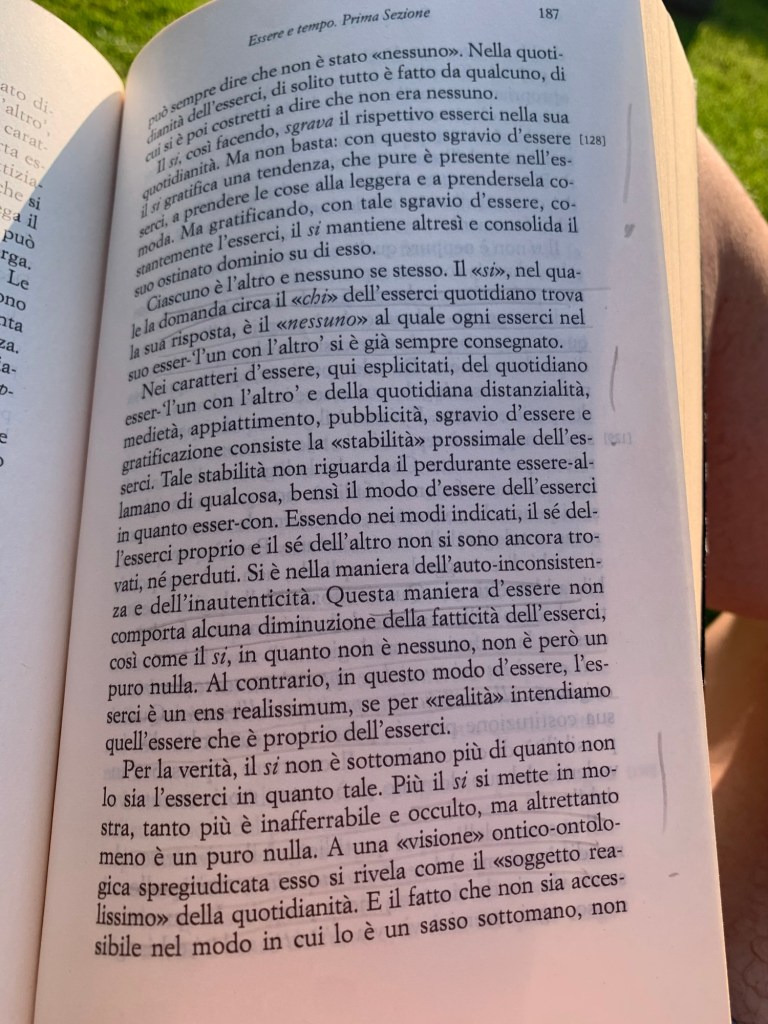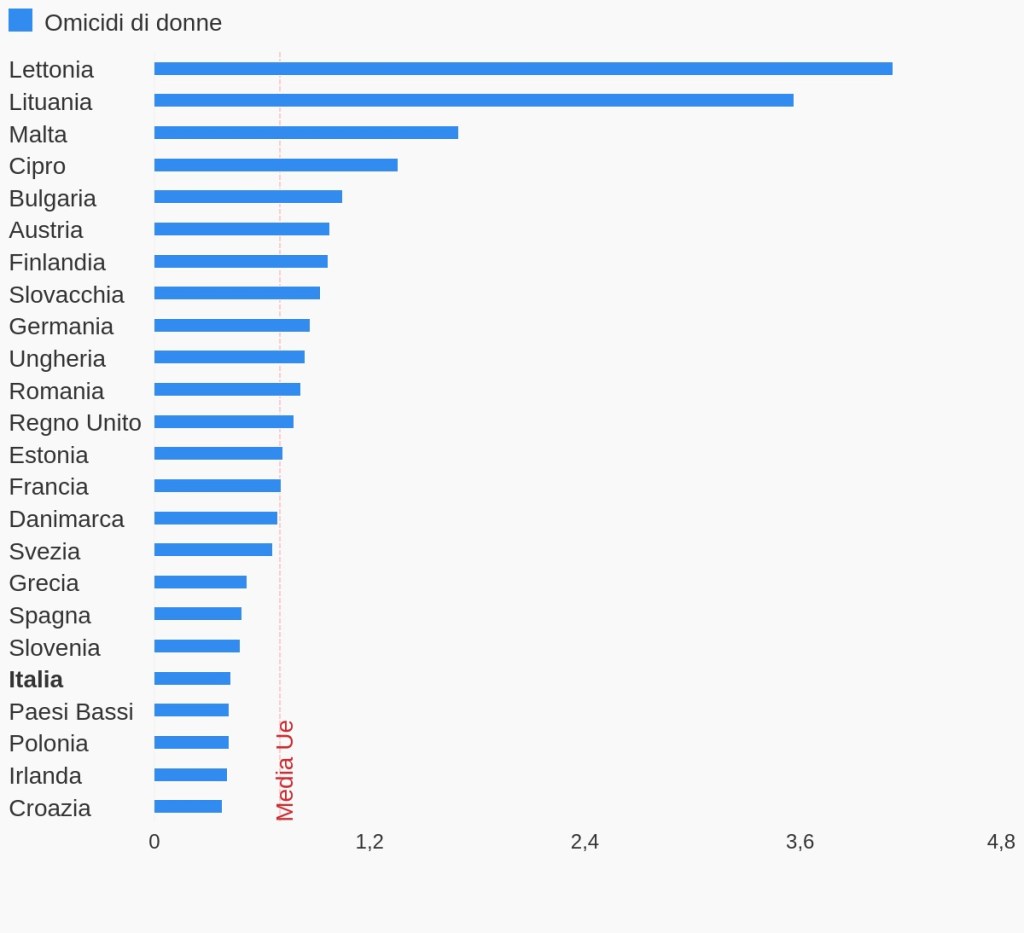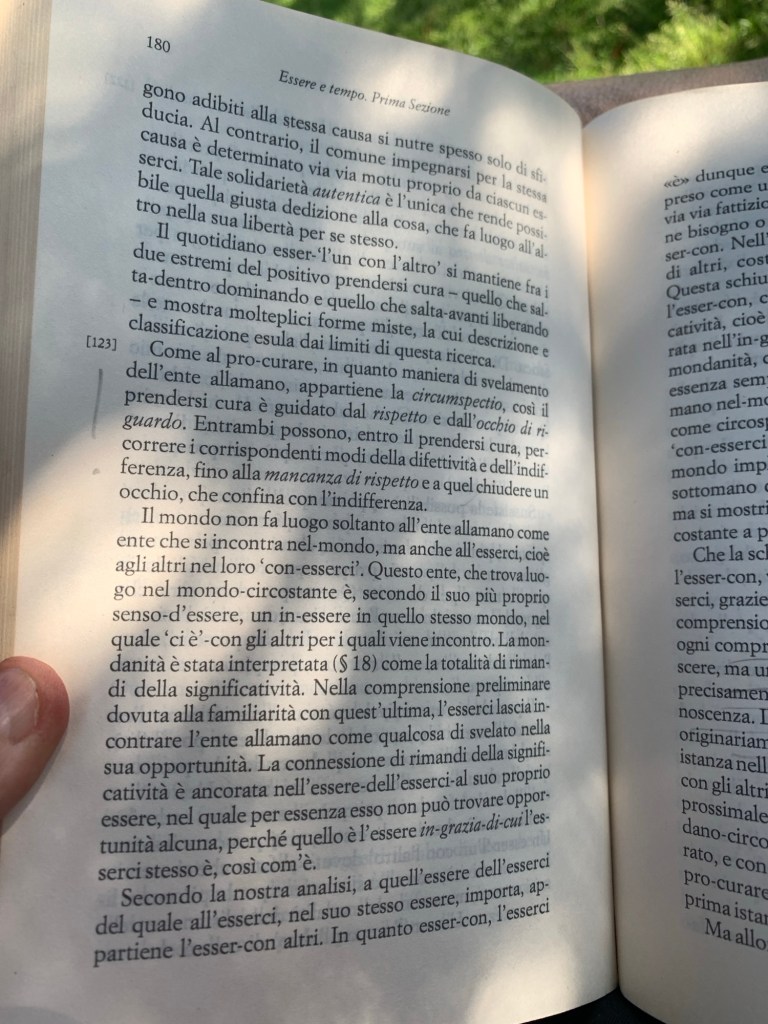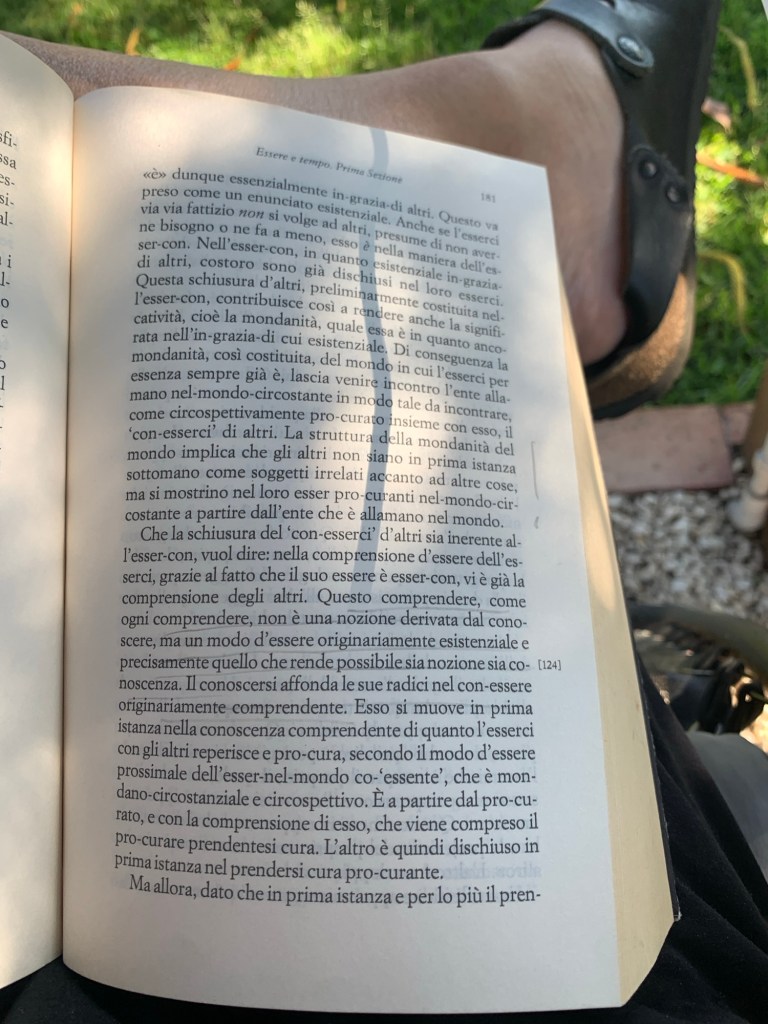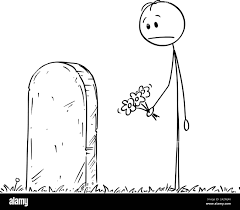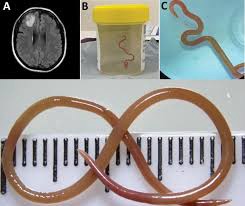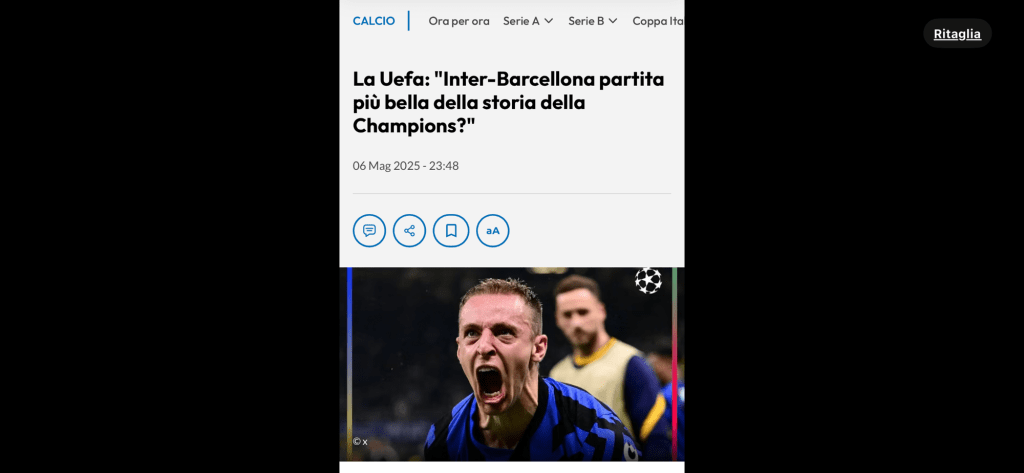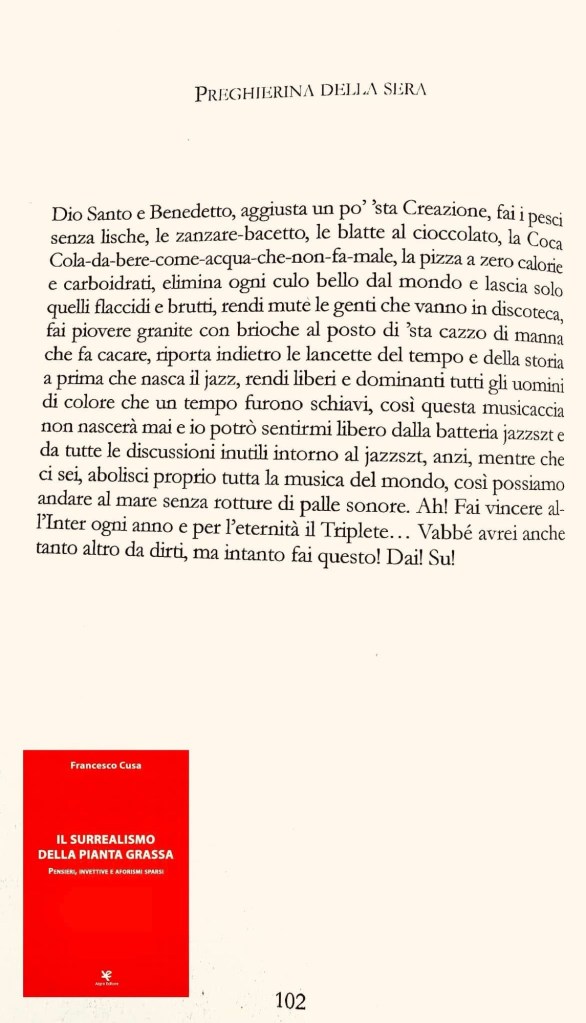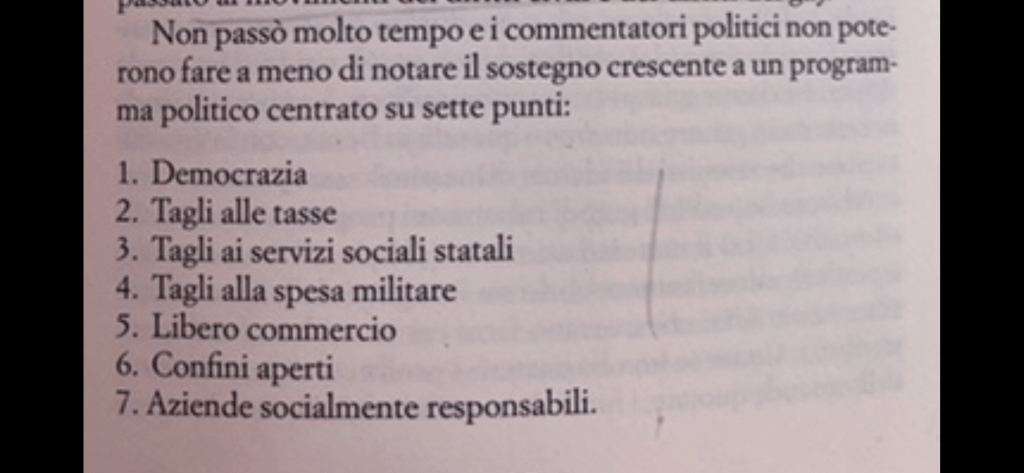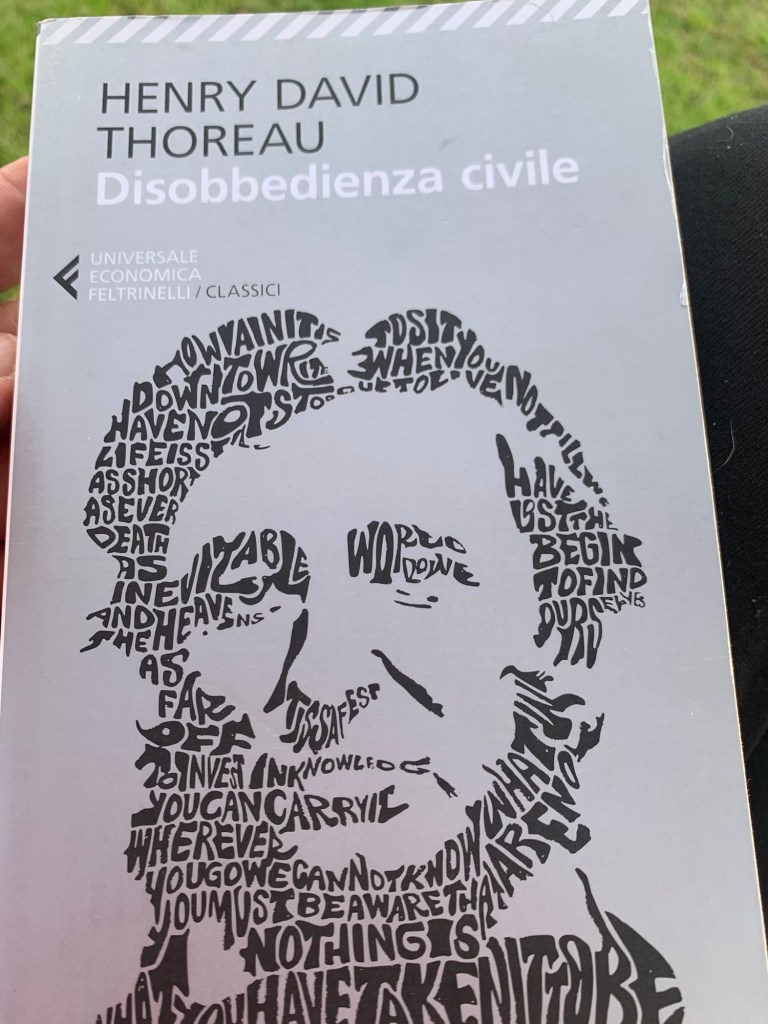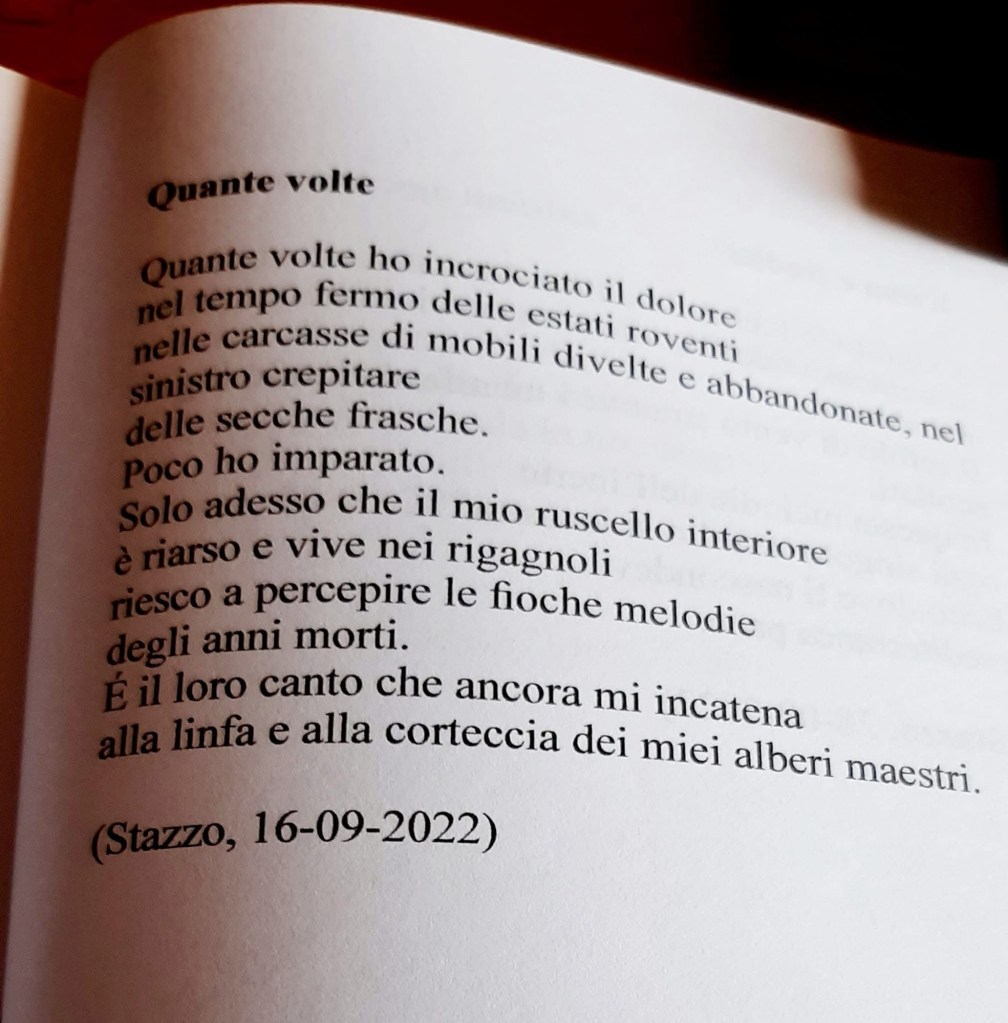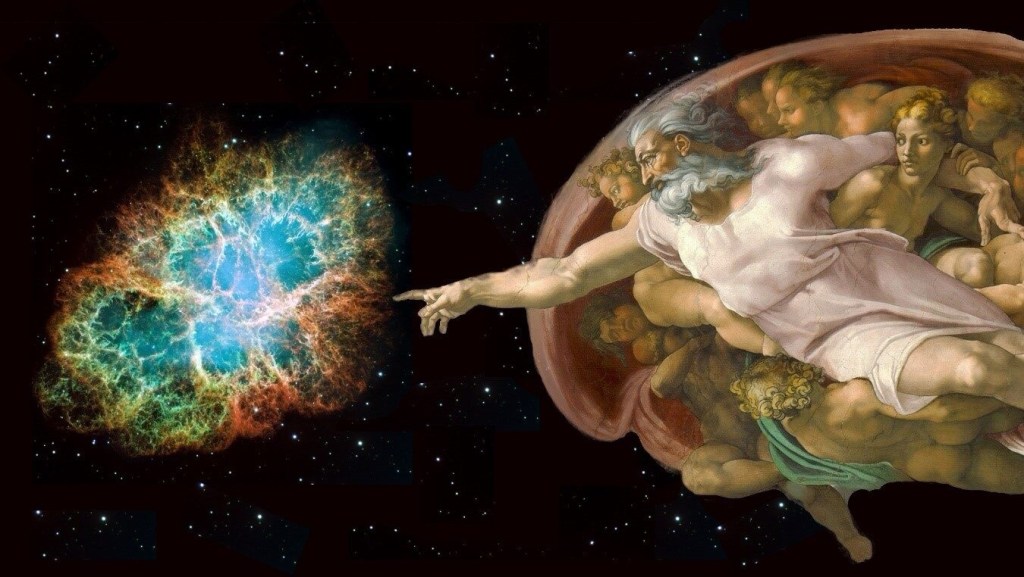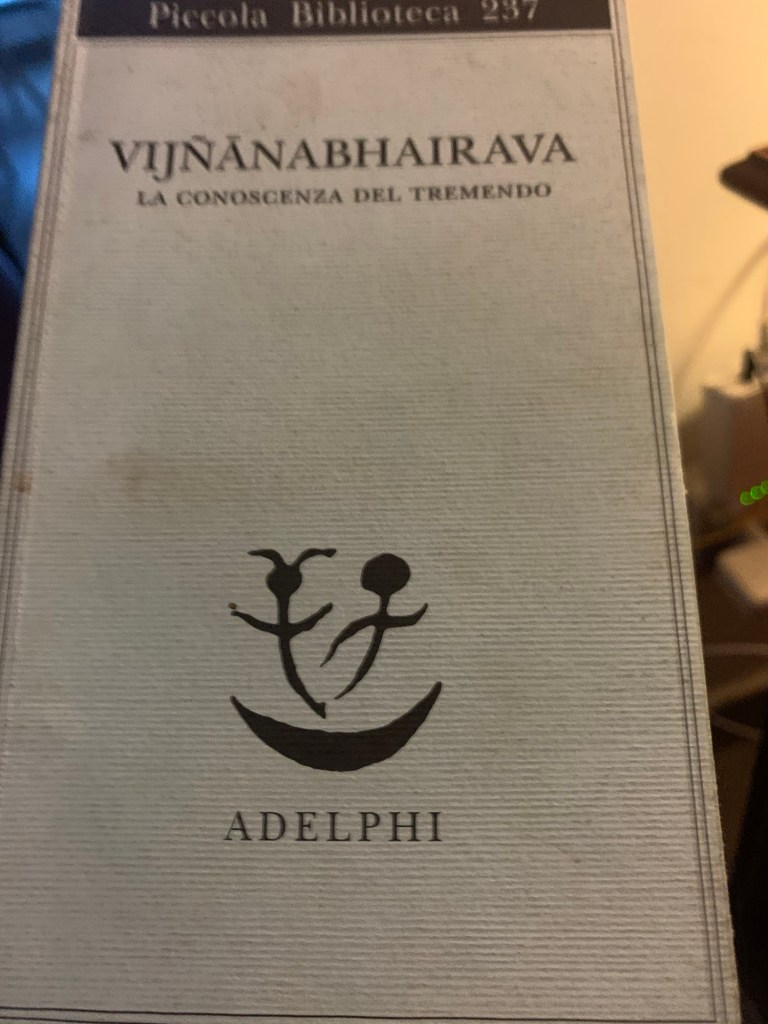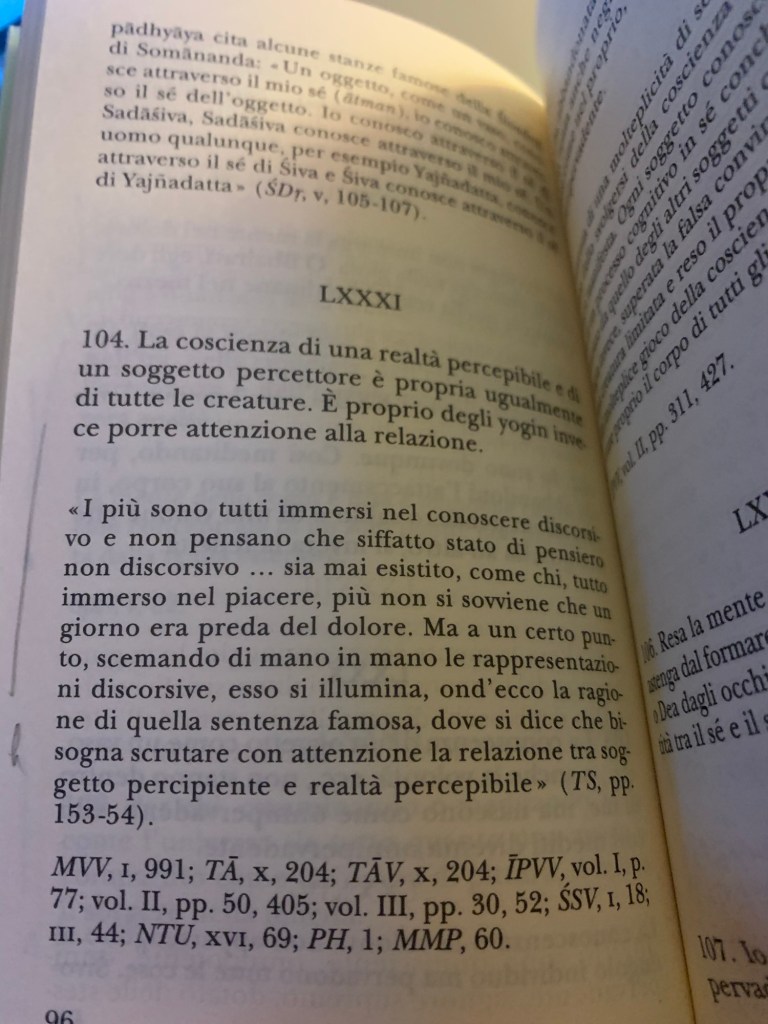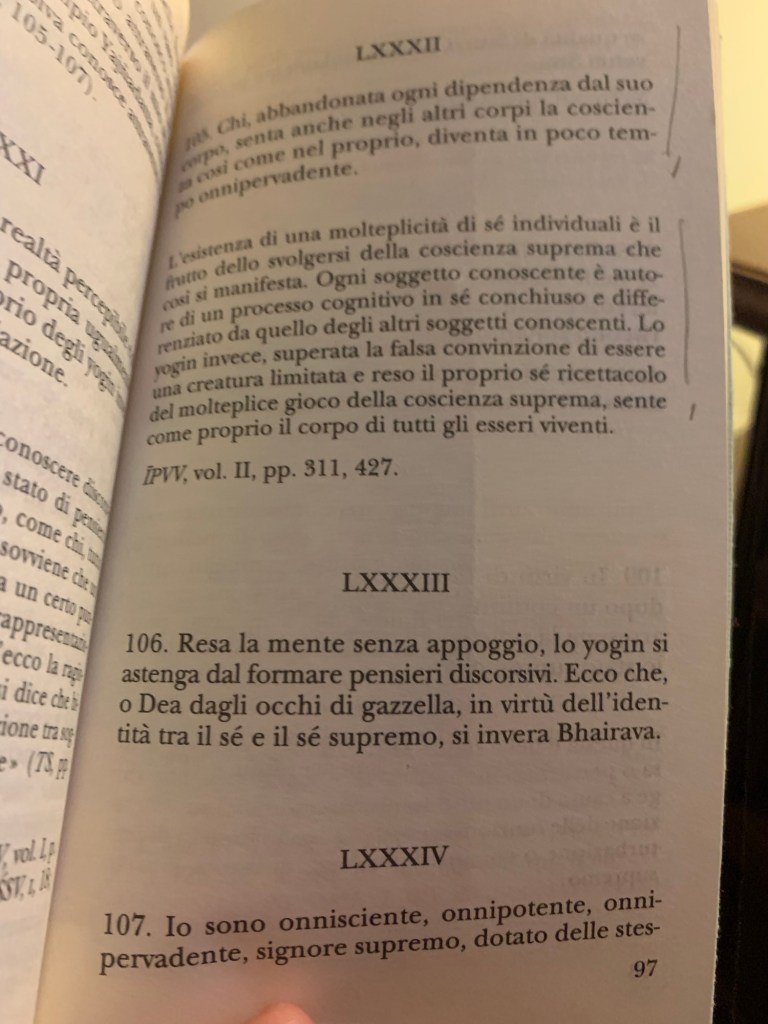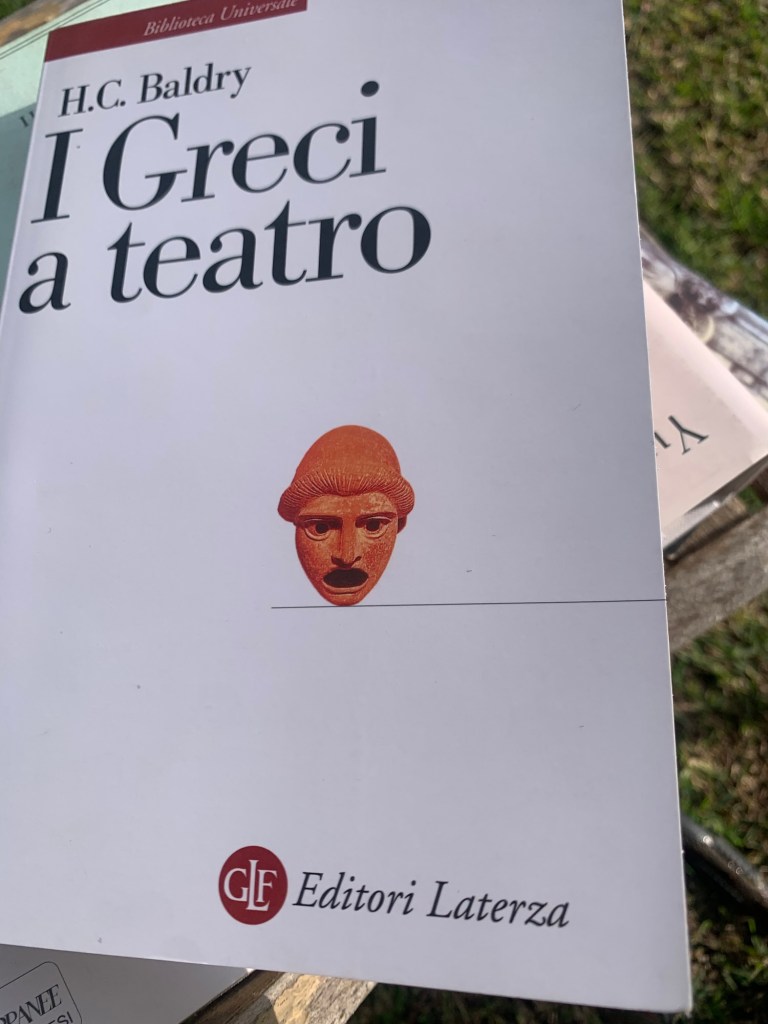Forma dell’Informe
Vorrei andare dentro ai quadri di Monet
per essere colore fra i colori
lucente come un colpo di fioretto
frutto consapevole d’una pennellata estrema
trascinata verso il basso della tela.
Spasmo, scaracchio della setola
gesto essenziale, irripetibile.
(Vampolieri 4-12-2020)
Non ricordo
Leggero come un rinoceronte alato
è il sogno rosa dell’altra notte
di cui poco ricordo
se non appunto il corno rosa
di ‘sto rinoceronte che volava.
Non ricordo nulla
e se ricordo qualcosa la dimentico ancora
mediante un processo dialettico raffinato
di cui non ricordo il metodo.
Eppure l’ho ideato io
il metodo.
Era un metodo perfetto
di cui però non ho ricordo
– la mente si rischiara
strizzata come una spugna rorida
ora giace asciutta e secca
nel torrido sole d’un mese che non conosco.
Per il resto non ricordo che il mio nome
forse anche il cognome e poco altro
non saprei ben dirvi che ho mangiato a pranzo
se questa è la notte o il mezzogiorno.
Non ricordo neanche il senso dei miei versi
se a scrivere è un estraneo o il sottoscritto
vorrei tanto cantar la mia saudade
e molto altro in questo cosmico sentire.
(Vampolieri 7-12-2020)
Settembre
Mi piace questo principiare d’autunno
quando l’aria si fa tersa
e lento è il declinare del sole
nello smorir del pomeriggio;
e poi ancora lì restare,
come attonito, in quell’attimo che precede il farsi d’aria ferma,
in quello spasmo di furente estate,
lì, sul ciglio della strada,
a ricordare il presente.
In una notte d’inverno
Fu in una certa notte d’inverno
che provai la solitudine.
Fu nel guardare con perfida malia
il denso costrutto pulsante nel niente
l’astratto grigiore, la patina lucida
che mi separa dagli oggetti di casa.
Dapprima fu un retrogusto, quasi un languore
più tardi una forma di sopportabile vuoto
una colla improvvisa di cui colsi l’essenza.
Ricordo era una notte di vento furioso
parevano l’urla di corpi straziati
e io col mio sguardo fisso in cucina
fissavo le porte e i lor movimenti
come un segugio confuso e ansimante.
Mi parve di scorgere fra scarti e stoviglie
un altro ricamo dell’esistenza
il canto silente del vivere inerte
come uno spasmo di assenza fremente.
Difficile esprimere l’immane contorno
che orla e separa lo spazio d’un niente
eppure è un abisso racchiuso in un punto
fra l’inerzia della tazza e la boria del bollitore.
Canicola
Combattere lo spleen della radiazione canicolare
pare esser divenuta la mia ultima lotta
ché vedo come scarnificata e ossuta
la reale natura della vita
col farsi dell’estate più cocente.
Insiste dolente nel pensiero
l’abbaglio d’una consapevolezza sorda
ed è come se la luce e il fuoco di giugno
svelassero con furia bellicosa
le povere fattezze del mistero.
E ciò che ne rimane messo a nudo
così, senza l’amore dei sapienti
reca grossa ambascia al petto e al cuore
e pare poca cosa, un mero scherzo
lo spasmo dilaniato del morente
o l’urlo di chi in vita giunge al mondo
che in mano stringe poco, quasi niente.
(Stazzo 18-6-2023)
Come una perenne teofania
C’è poi questo senso del vivere
che si fa memoria al passo
per le strade assolate del paese
(rimanda a quelle cose ormai trascorse
mentre emoziona dell’onde
la tragedia dello schianto sui bastioni del porto).
E quel poco d’ombra mia ch’ormai s’avvita
al mezzogiorno della meridiana della chiesa
a me pare il segno d’una ritrovata estraneità
nient’altro che il vapore di un incantamento.
Cielo fermo
Provo angoscia per l’imminente arrivo dell’estate
quando la luce torrida mostrerà
le piaghe virulente delle strade di catrame
quando arrancheremo
con la fatica dell’insetto
non più figli di Vitruvio
nella nostra offesa nudità.
(Stazzo 7-4-2023)
Pistoleri
Sostavamo nell’ombra giallo ocra
per deserti della mente
in uno stallo messicano.
Eravamo poveri e affamati.
Eravamo disposti a uccidere.
Estrassi la pistola e feci fuoco
in direzione del tramonto.
Ora il mio corpo giace
sulla terra rossa degli avi
mentre una finestra di memorie
sembra chiudersi per sempre.
L’eternità puzza di polvere da sparo.
(Stazzo 22-4-2023)
Genesi
Immobili come ancore ai fondali
nutriamo di tempo le nostre vitree icone
nell’attesa di un’azione che ci renda umani
di una storia che illumini le ombre
e che ci renda degni di apparire al mondo.
(Stazzo 2-6-2023)
Inesorabile
Nel corpo si fonda la Legge
solo memoria
carnale memoria.
Scorre la polvere nella clessidra
grano a grano
nella soave indifferenza della notte
vibrano le fiammelle nei cimiteri.
Giunge roco e improvviso
lo straziante urlo del gallo
che fa palpitare i cuori di terrore
mentre immote, come rapprese,
stan le frasche
ai venti dei sottosuolo:
sono le due e trentaquattro
di una notte diversa.
(Stazzo 16-6-2023)
Estasi
L’Entità che srotola il tappeto del firmamento
dev’essere maestra di seduzione
e avvezza alle più sofisticate arti
della fascinazione,
se questo struggente miracolo d’adesso
mi rende così ebbro di stupore
e al contempo vigile come una volpe ferita.
(Stazzo 30-6-2023)
Notte di luglio
Soffia meraviglioso vento dell’estate
la notte è inebriante e piena di profumi
colano d’afrori le frasche al loro canto.
Io mai penso d’aver provato simil gioia:
vedere la mia vita dispiegarsi
un manto dai lucori argentei
che avvolge soavemente la mia finitezza
tale venerea manifestazione, dico,
che squarcia e polverizza il cuore
mi provoca un delirio immenso
e di piacere mi sconquassa l’anima.
Contemplo questa mia liquefazione
come il miracolato fa con le reliquie del suo corpo sanato…
arde l’irrelato istante che mi lega al tutto
e brucio del fuoco siderale del devoto.
(Stazzo 2-7-2023)
LIBRI- FRANCESCO CUSA: BUY HERE BOOKS AND CDS.
– Tutti i miei libri finora editi
1. VIC – (romanzo) https://www.lafeltrinelli.it/libri/francesco-cusa/vic/9788893414821
2. IL SURREALISMO DELLA PIANTA GRASSA: (saggio) https://www.amazon.it/surrealismo-grassa-Pensieri-invettive-aforismi/dp/8893413418
3. STIMMATE: (poesie) https://www.ibs.it/stimmate-libro-francesco-cusa/e/9788893412506
4. AMARE, DOLCI PILLOLE: (aforismi) – “Infoshop”
5. CANTI STROZZATI: (poesie) https://www.unilibro.it/libro/cusa-francesco/canti-strozzati/9788867703432
6. RIDETTI E RICONTRADDETTI: (aforismi) https://www.unilibro.it/libro/cusa-francesco/ridetti-e-ricontraddetti/9788898721467
7. NOVELLE CRUDELI: (racconti) https://www.ibs.it/novelle-crudeli-dall-orrore-dal-libro-francesco-cusa/e/9788898644032
8. RACCONTI MOLESTI: (racconti) https://www.amazon.it/Racconti-molesti-Ediz-illustrata-Francesco/dp/8898644418
9. NEI DINTORNI DELLA CIVILTÀ – De Felice Edizioni – https://www.ibs.it/nei-dintorni-della-civilta-libro-francesco-cusa/e/9788894860702
10. NAKED PERFORMERS – Elementi di Conduction (e book) – https://itunes.apple.com/it/book/elementi-di-conduction/id910169093?l=en&mt=11
11 IL MONDO CHIUSO – Robin Edizioni – https://www.ibs.it/mondo-chiuso-libro-francesco-cusa/e/9788872749067
12 IL GIUSTO PREMIO – Robin Edizioni – https://www.mondadoristore.it/Il-giusto-premio-Francesco-Cusa/eai979125467712/
13 L’ORLO SBAVATO DELLA PERFEZIONE – Algra Editore – https://www.algraeditore.it/saggistica/lorlo-sbavato-della-perfezione-cogitazioni-dellera-dellaccelerazione/
14 “2056” – Edizioni Ensemble – https://www.amazon.it/2056-Francesco-Cusa/dp/B0DTX8WB63